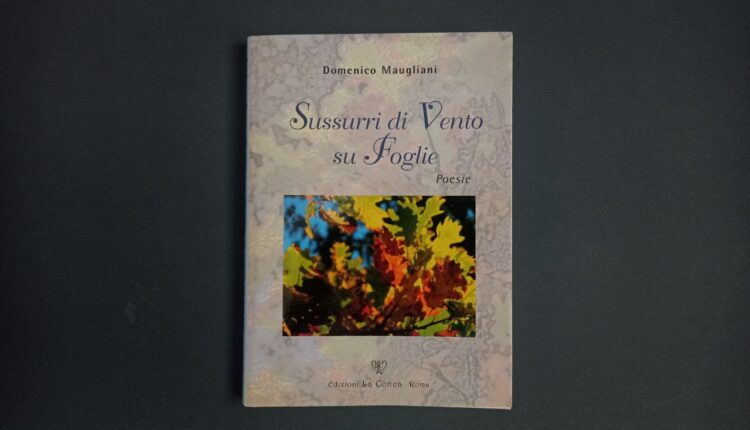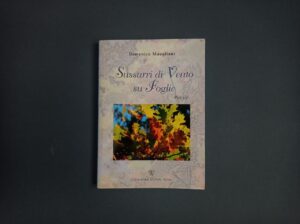 Vicovaro – Per avvicinarsi alla poesia locale è necessario, di solito, modificare il proprio approccio: mettere tra parentesi il giudizio estetico, la fattura del testo, e rafforzare, per contro, lo sguardo socio-antropologico e l’interesse per la specificità di una scrittura che nasce in un preciso, magari micro-, contesto. È comprensibile, infatti, che un piccolo paese, privo, prima ancora che di tradizione letteraria propriamente detta, anche di centri culturali stabili, duraturi ed efficaci, riproduca, nelle episodiche opere letterarie, linguaggi e immaginari che faticano a smarcarsi dallo stereotipo.
Vicovaro – Per avvicinarsi alla poesia locale è necessario, di solito, modificare il proprio approccio: mettere tra parentesi il giudizio estetico, la fattura del testo, e rafforzare, per contro, lo sguardo socio-antropologico e l’interesse per la specificità di una scrittura che nasce in un preciso, magari micro-, contesto. È comprensibile, infatti, che un piccolo paese, privo, prima ancora che di tradizione letteraria propriamente detta, anche di centri culturali stabili, duraturi ed efficaci, riproduca, nelle episodiche opere letterarie, linguaggi e immaginari che faticano a smarcarsi dallo stereotipo.
Come dicevo, però, questo non implica l’impossibilità di leggere questi lavori in altri modi, e non ultimo mettendoli in relazione, proprio, all’assenza della tradizione. In questo modo bisogna a mio avviso avvicinarsi ad esempio a Sussurri di vento su foglie di Domenico Maugliani, poeta vicovarese classe 1939, scomparso nel 2004. Il libro – uscito postumo, nel 2005, per Edizioni La Conca, con prefazione di Romeo Iurescia – apre una sorta di panoramica sulla produzione dell’autore (le poesie datate spaziano dagli anni ’60 ai primi del 2000) e testimonia proprio la “costituzione locale” cui accennavo.
La divisione in due sezioni, soprattutto, è significativa, e evidenzia una serie di questioni che toccano la maggior parte degli autori che rimangono particolarmente legati al proprio territorio (come Maugliani, impiegato al Comune e Segretario del PCI di Vicovaro). La bipartizione, chiaramente, è in primis di natura linguistica, ma di conseguenza, come ora vedremo, anche culturale e ideologica. La prima sezione, senza titolo, è infatti in italiano, e non a caso rappresenta tra le due quella meno riuscita. I testi che vi compaiono sono soprattutto di ispirazione paesaggistica e confessionale, e con un lessico oscillante tra il piano quotidiano («Una candela bruciava, / sul tavolo, i piccini / aspettavano, nella notte, / il suono della mano, furtivo, / alla porta, per vivere») e il prezioso («Dissonanti accordi / d’elitre suggono / linfe di salici»), in versi spesso brevi e non senza, questo sì, una certa accortezza per l’enjambement, il ritmo e l’incastro sonoro («Tra corone di dalie, / di gladioli e crisantemi; / funebre, di cipressi; / egizia, di palme; araba»; «Dalla grotta il fiume / bianco si snoda»), puntano a indagare la tradizionale risonanza tra il paesaggio (spesso meraviglioso) e l’io lirico.
Di conseguenza, i momenti migliori sono proprio quelli in cui questo incanto viene interdetto da altri elementi, tra cui menzioniamo la violenza («Giovani mani bruciano / di tritolo»), la storia («La giovane / italiana sapeva i discorsi / del regime, a memoria»), la citazione colta («Com’era difficile, / allora, / il mestiere di vivere!», reminiscenza da Pavese), la politica, anche nella sua versione più cronachistica (si citano ad esempio «Romano Prodi» e «l’Ulivo»), la religione («Ho voglia di pregar, ma le parole, / se non m’aiuti, non ricordo, madre»), nonché una malinconia, più tangibile e seria, per quanto riguarda le poesie scritte verso la fine della vita, di maggiore impatto («Sto racchiuso in quest’angolo di muri, / dove pare che è mio questo squarcio / di cielo tempestoso, che m’assale, / dentro una culla verde, alla deriva, / nel fiume che straripa nella valle.»). Non ultima ricordiamo anche la condizione di doppia geografia, a cui Maugliani accede attraverso la moglie lucana Carmela Naccarati e da cui derivano l’attenzione poetica all’“altro luogo” (Lucania, proprio, è il titolo di un testo), ma anche una comunanza complementare con un altro autore vicino, il siculo-vicovarese Isidoro Console La Rosa.
E il luogo, chiaramente, è il centro della seconda sezione, Canti vicovaresi, tutta, appunto, in dialetto vicovarese (e con tanto di foto d’epoca). Anche questa parte, chiaramente, non è esente da una certa ideologia del testo, e anzi proprio questo è il punto, di come le due lingue producano le rispettive ideologie letterarie: l’italiano, per tradizione alla lunga petrarchesca, stimola la confessione; il vernacolo, per tradizione alla lunga belliana, la satira. Credo sia un punto importante definire il vernacolo come ideologia, ma è un discorso che destinerò a un’altra sede. Per tornare a Maugliani, ciò che bisogna notare è dunque il cambio di tono, che nella sezione dialettale abbandona i preziosismi, si intride di linguaggio popolare – ovviamente – e soprattutto si concede al gioco, allo scherzo, alla polemica, cosa che dota di una patina di ironia anche gli inevitabili momenti nostalgici e pittoreschi (immancabile la poesia-bozzetto Vicuaru).
Tuttavia è in questo scherzo, quindi, che Maugliani si libera dell’inibizione indotta dall’italiano e schiude gli aspetti più interessanti del libro, che sono proprio quelli che innestano la scrittura al paese, inteso come vita sociale o background culturale. Questo innesto può avvenire ad esempio attraverso la specificità della lingua: significative in questo senso appaiono la poesia La sperella (in cui il tema ultra-classico del tramonto è sovrapposto proprio all’intraducibilità, quindi esegesi, del termine-concetto di «sperella», che, da «vesper», indica l’ultima luce de giorno), la poesia J’appizzutalàpisse (giocoso testo sul rapporto tra l’ispirazione e il temperino, reso dal dialettale-monstre «appizzutalàpisse») e la poesia Lo rapacciu (in cui si intrecciano i dialoghi tra i paesani e la speculazione etimologica di «rapacciu», lo sporco adeso all’epidermide fatto risalire al latineggiante «rapacius», rapace).
Ma l’innesto può soprattutto avere a che fare con il contesto sociale in cui il poeta è inserito. Da questa strada vediamo Maugliani ancora alle prese con la politica, ad esempio, che perde però i connotati propagandistici e diventa, invece, occasione di satira paesana («Denanzi alla Madonn’ ‘e lla Cappella / ténémo la Domenica in… DDI’ – CCI’», «Quistu Violenzio arìva da pe’ ttuttu, / spece mò, ch’è ‘n’amicu d’Andreotti»); oppure con la cultura, a sua volta raccontata goliardicamente attraverso i suoi rocamboleschi attori locali (come ne La curtura, che si apre con l’appellativo «Angelo me’!», rivolto ad Angelo De Simone, celebre, per i vicovaresi, uomo di cultura) oppure in vena polemica (memorabile a proposito la satira La scaroggna, rivolta al premio di poesia dialettale Mezzaluna, cui parteciparono anche altri autori vicovaresi, come Biagio Liberti e lo stesso Angelo De Simone, ma in relazione al quale Maugliani lamentava il proprio insuccesso: «Non me rérèsce d’acchiappa’ ‘na tacchia / a quéssa Mezzaluna de Mentana / […] Ce sta quissu grammaticu de Roma, / me seggna rossce tutte le parole, / specie se parlo de democrazzia.»).
Insomma, come il cambio di lingua sdogani un cambio di registro, che è però anche un cambio di prospettiva culturale-ideologica, mi sembra l’aspetto più interessante che possiamo osservare a partire da questo libro, e che riguarda, oltre Maugliani, la condizione generale del poeta che scrive fuori dai centri di produzione culturale (e prima, anche, della definitiva invasione dei media). Una condizione che, poi, nello specifico di Maugliani e dei Canti vicovaresi, produce una divertente esplorazione del mondo vicovarese, che ha il suo valore storico, sociale e linguistico soprattutto se messa in relazione a un contesto che non ha mai avuto una tradizione letteraria solida e specifica – come spesso è, per i piccoli luoghi delle aree interne.